L’intervista – parte II
Prima citava che all’inizio della sua carriera la difficoltà maggiore era quella di mantenersi in contatto fra colleghi, soprattutto per comprendere a che livello erano gli studi che si stavano compiendo. Oggi ben difficile da immaginare anche solo con internet, però mi ricordava anche un’altra difficoltà.
Avevamo una biblioteca, a quei tempi, in cui c’era poco e niente. I contatti, insomma, non sapevi nemmeno a chi chiedere, in Osservatorio non c’era nessuno che si fosse occupato di planetologia. Quindi eri proprio isolato. Tanto per fare un esempio di quanto sia importante essere a conoscenza degli studi già effettuati, mi ricordo che mi ero messo a studiare gli elementi orbitali, all’epoca c’erano un migliaio di asteroidi catalogati. Provai a plottare (tracciare un grafico, NdA) semiasse ed eccentricità, semiasse ed inclinazione a mano, pensando che ci fosse qualche legame.
Ad un certo punto ho visto che sia in un piano che nell’altro c’erano delle concentrazioni che ad occhio erano fuori dalla statistica e le mostrai al direttore che disse che erano interessanti. Eravamo ad inizio anni ’70 e pensai che fosse possibile che altri ci fossero già arrivati, io avevo perso un bel mese a plottare tutti i dati. Allora mi recai nella vecchia biblioteca, umida e piena di ragni. Trovai un lavoro di un giapponese che risaliva al 1914 dal titolo “Family of asteroids”, Famiglie di asteroidi! Già con 200 oggetti aveva visto le stesse cose che avevo trovato io. Ad ogni modo questo m’insegnò che non puoi sperare di inventare le cose, bisogna informarsi ed avere contatti, ma da allora le Famiglie di asteroidi non le ho più abbandonate anche se poi mi sono occupato dei satelliti di Saturno in particolare di Iperone.
Ad ogni modo applicai il metodo statistico della minima distanza alle Famiglie di asteroidi, che sembrerebbe abbastanza normale, ma nessuno lo aveva ancora applicato perché avevano sempre fatto studi “occhiometrici”. Bisognava anche trovare una metrica ed io utilizzai la velocità relativa tra oggetti mediante le formule di Gauss che usano le differenze degli elementi orbitali. Questo metodo è quello che mi ha dato maggior soddisfazione, infatti, ancora oggi mi fa piacere vedere su Wikipedia “Zappalà et al.”, è una rivincita da quando ho fatto il primo lavoro che era già stato studiato dai giapponesi sessant’anni prima.
Un altro problema era la visibilità scientifica. Fino al 1982 era ben difficile per noi italiani ed europei in genere pubblicare su Icarus, in quanto i referee (le persone incaricate dalle riviste scientifiche di leggere i lavori sottomessi e dalle quali dipende l’approvazione o meno alla pubblicazione, NdA) erano solo americani, che nemmeno citavano i lavori apparsi su A&A (Astronomy and Astrophysics una rivista europea del settore, NdA) perchè non l’avevano in biblioteca.
Con le famose liti di Dubrovnik prima (sui metodi dei poli degli asteroidi) e soprattutto Patrasso poi contro i maggiori nomi americani e l’editore in capo di Icarus, le cose sono drasticamente cambiate e da allora un referee europeo è stato sempre presente in Icarus. A mio modesto parere questo è stato il mio più grande successo scientifico non solo per Torino e l’Italia, ma per tutta l’Europa planetologica.
Potrebbe far capire meglio quale era la gestione delle riviste scientifiche per i non addetti ai lavori?
Per spiegarmi meglio, con il mio carattere un po’ siculo, non sono mai riuscito a digerire tanti compromessi e tutto parte da Icarus che è la rivista di riferimento per i planetologi, come può essere Astrophysical Journal per gli astrofisici.
All’$epoca$ Icarus era estremamente ghettizzata. La prima volta che ero riuscito a far pubblicare un mio lavoro era in occasione del Congresso su Eros al quale accennavo prima, perché avevano fatto un‘edizione speciale. Pubblicare normalmente sulla rivista non si riusciva, i referee erano sempre americani e le risposte che davano non erano molto coerenti. Me ne ricorderò sempre una che commentava un lavoro proposto e che diceva che non aveva niente di sbagliato, ma non piaceva. Una cosa scientificamente assurda. Chi aveva mandato questo responso, ora è un mio caro amico, ma non è una risposta di un referee.
Il colmo si raggiunse quando un nostro lavoro fatto con i colleghi pisani in cui si dimostrava che tutto quello che era uscito prima sull’evoluzione collisionale era una grande panzana fornendo delle prove con i dati prodotti da una statistica accurata. Pubblicato su Astronomy and Astrophysics, perché era la nostra rivista di allora, non letto da nessun americano o se letto avevano la scusa che non c’era nelle loro biblioteche; due anni dopo uscì un articolo su Icarus dove si ritrovavano le nostre conclusioni.
Durante il congresso IAU ( International Astronomy Union) chiamai l’editore di Icarus, un autore di questo articolo e qualche altro personaggio influente. Brevemente dissi che quello che era successo era ignobile. Le cose cambiarono per tutti perché da allora venne inserito, per maggior garanzia, sia un referee americano che uno europeo.
Cambiano argomento, a che livello qualificherebbe la planetologia svolta presso l’Osservatorio Astronomico di Torino?
Era il lavoro svolto che faceva di Torino un centro planetologico di assoluto livello. Da molte nazioni c’erano giovani che chiedevano di passare un po’ di tempo da noi; basta ricordare Hestroffer, Bendjoia, Michel, Muinonen, Knezevic, ecc.
Recentemente l’Osservatorio di Torino ha presentato una mostra in occasione dell’Anno Internazionale dell’Eliofisica e dei 50 anni dell’esplorazione dello spazio, nonostante il fascino degli argomenti cosmologici ho avuto modo di vedere che l’oggetto che più affascinava gli occhi di grandi e piccini, oltre ai modelli dei satelliti, era sicuramente l’unico di provenienza extraterrestre: un meteorite. La stupisce e cosa ne pensa?
Un po’ mi stupisce, però forse è un po’ come il football rispetto agli altri sport. Secondo me è molto più bella ed atletica la pallavolo, però una persona normale può fare anche una partita ed un gol, ma fare le azioni della pallavolo è ben più difficile! Le cose troppo lontane sono affascinanti, ma ciò che viene dallo spazio e puoi toccare è un’altra cosa…
Se si parla con un egittologo da profani si finisce per chiedergli del mistero che avvolgerebbe la costruzione delle Piramidi; ad un planetologo non si può non domandare di Tunguska? E’ mai stato su questo “luogo del delitto”? Alla luce delle nuove teorie cosa ne pensa cometa o meteorite?
Tunguska è un evento studiato, ma non ancora chiaro. Il laghetto che si vede forse è d’origine d’impatto. Per il tipo di esplosione dovrebbe essere un grosso meteorite e non una cometa, ma quando è accaduto si era in un periodo critico e il posto ben lontano dalla civiltà. Si raggiunse il luogo dell’evento solo dopo anni. Ad ogni modo non ci sono mai stato, un posto non bello, dove persino le ferite non si rimarginano per via dell’aria talmente secca. E poi piena di zanzare.
Si parla molto dei NEO (NEAR Earth Objects) e del loro monitoraggio; recentemente è stato pubblicato un libro dal settore della protezione civile della Regione Piemonte che la vede tra gli autori. Pensa che le strategie che si adotteranno per evitare un’eventuale catastrofica collisione con la Terra siano fantascienza o siano fattibili? A questo proposito si è molto parlato di Apophis: un asteroide di circa 400 m che dovrebbe impattare la Terra nel 2036, può dirci qualche cosa di più a riguardo?
Prima di tutto il rischio di Apophis è rientrato, e le strategie proposte sono quasi fattibili, ma il problema più grande è la politica. Infatti, l’ultima idea è quella di realizzare per questo tipo di problema un “trattore gravitazionale”. L’energia necessaria non è così difficile da ottenere, il problema è che, mentre il trattore “tira” gravitazionalmente l’asteroide, il punto d’impatto si muove su una linea sulla Terra. Chi dovrebbe decidere quando fermare il trattore? Questo oggetto inoffensivo potrebbe diventare pericoloso.
Facciamo un esempio: si stima che l’asteroide impatti sulla California e si adotta il “trattore gravitazione” per scongiurare questa catastrofe; poi però chi può assicurare che, durante lo spostamento, magari qualcosa non funzioni e tutto si interrompa quando l’impatto è, ad esempio, sull’Africa? Chi può prendere politicamente la decisione di fare questo? E se addirittura fosse usato come arma?
Se avesse avuto la possibilità di vivere in un mondo ideale, con fondi praticamente illimitati, per la ricerca, avrebbe compiuto diverse scelte in determinate circostanze? Si sarebbe lanciato in progetti ambiziosi e quali?
Non penso, sono stato contento di aver affrontato un argomento considerato un po’ marginale, ma completamente nuovo. L’unico pensiero va ad un progetto presentato negli anni ‘80 all’ASI, la missione PIAZZI. Si voleva andare su Eros, ma avevano dato pochi soldi per lo studio di pre-fattibilità e con questo si è concluso. Anni dopo nel ’97 la missione fu fatta (NEAR), ma non dall’Italia…
Vorrebbe terminare con un’ultima news?
Il 30 gennaio vi è una probabilità di 1/75 (più dell’1%) che un asteroide di circa 50 metri di diametro cada su Marte. Niente di tragico, ma se cadesse, ad esempio, su Alba farebbe fuori gran parte delle zone del magnifico nettare, dal Barolo al Roero. Sarà un bello spettacolo probabilmente visibile con medi telescopi. Questo ci deve far pensare che prima o poi capiterà anche a noi.
Invece di spendere miliardi e miliardi nel riscaldamento globale, che è ancora tutto da dimostrare, si potrebbe pensare seriamente anche a fronteggiare questo tipo di pericolo. E poi pensate che Marte è molto più piccolo della Terra e quindi ha molte meno probabilità di essere colpito… Comunque questa volta ci è andata bene.

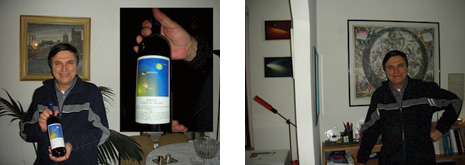
Molto interessante e ben fatto. 😆 😛
..devo dire che anche per “intervista” riesce ad essere comprensibile, come nelle sue conferenze.. 😆
Grazie Anna! 😉