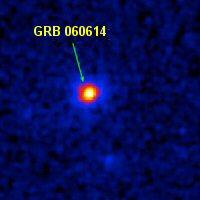
GRB 060614
“Immaginiamo di essere nel bel mezzo di un temporale e di assistere a un lampo davvero imponente. Istintivamente tendiamo le orecchie aspettando il rimbombo di un tuono altrettanto imponente. E invece nulla, silenzio assoluto”. A proporre questo esempio è Johan Fynbo (Università di Copenaghen – Danimarca), autore principale di uno studio pubblicato sul numero di Nature del 21 dicembre riguardante due enigmatici lampi gamma. Sempre sullo stesso numero della prestigiosa rivista e sempre sul medesimo argomento possiamo leggere anche altri tre studi, uno dei quali è opera di un team composto quasi esclusivamente da italiani e vede come primo autore Massimo della Valle (Osservatorio Astrofisico di Arcetri).
I due lampi gamma che hanno suscitato tanto interesse sono stati rilevati il 5 maggio (GRB 060505) e il 14 giugno di quest’anno (GRB 060614). Si è trattato di due impulsi gamma certamente appartenenti alla classe dei cosiddetti lampi lunghi, cioè quegli eventi la cui durata supera i due secondi. Il GRB di maggio, infatti, si è protratto per 4 secondi, mentre quello di giugno è durato ben 102 secondi.
Secondo le interpretazioni correnti – corroborate ormai da quasi un decennio di osservazioni – i lampi gamma che hanno durata più lunga sono da ricondurre agli attimi conclusivi dell’esistenza di una stella, allorchè, esplodendo come supernova, origina un buco nero. I lampi di minore durata, invece, si ritiene siano il segno di un evento completamente diverso, vale a dire la fusione di due stelle di neutroni oppure la cattura di una stella di neutroni da parte di un buco nero. Questo spiega come mai ai lampi lunghi è sempre associata una brillante supernova, assente invece in occasione dei lampi gamma più brevi.
I due lampi del 5 maggio e del 14 giugno, però, non sono stati accompagnati da nessuna supernova. Benchè le galassie in cui si sono verificati i due eventi siano state tenute d’occhio sia con il VLT dell’ESO che con il Keck Telescope alle Hawaii, non si è rilevata la minima traccia di supernova. Sembra quasi che il loro comportamento metta assieme le caratteristiche salienti di entrambe le classi: emissione energetica prolungata e nessuna supernova associata.
Davvero complicato trovare una spiegazione. Poco percorribile l’ipotesi che la luce della supernova ci sia sfuggita: questo vorrebbe dire che l’esplosione stellare è stata almeno 100 volte meno intensa di quelle solitamente associate agli altri lampi gamma. Gli astronomi, però, non brancolano nel buio. Nei lavori pubblicati su Nature, infatti, si suggerisce un possibile scenario: il buco nero originatosi con la supernova potrebbe essere talmente massiccio da trattenere tutta quanta la materia stellare. Il materiale che solitamente viene sparato tutt’intorno nell’esplosione di una supernova, insomma, sarebbe stato trattenuto e voracemente ingoiato dal buco nero. Uno scenaio che farà sicuramente discutere, anche se sembra ormai accertato che in entrambi i casi le due stelle progenitrici fossero state davvero di massa elevata.
Insomma, chi ormai pensava di occuparsi d’altro perchè la questione dei lampi gamma sembrava definitivamente archiviata deve ricredersi. Di lavoro ce n’è ancora un bel po’.
Fonte: http://www.coelum.com
