Ogni 120 anni circa, una macchia scura scivola lungo il sole. Piccola, nera come l’inchiostro, quasi perfettamente circolare…non è una macchia solare comune. Non tutti riescono a vederla, ma alcuni che lo hanno fatto dicono di aver provato una sensazione strana, come di avere i piedi immersi nella sabbia sulla spiaggia di un’isola del Pacifico del sud.
Il 12 agosto del 1768, la nave di Sua Maestà Bark Endeavour (il cui nome ispirò il nome dello Space Shuttle Endeavour) salpò dal porto di Plymouth al comando di James Cook, in rotta verso Tahiti. L’isola era stata scoperta dagli europei solo un anno prima nel Pacifico del sud, una regione della Terra così poco esplorata che i cartografi non sapevano dire se contenesse un vasto continente o meno. Era come se Cook stesse andando sulla Luna o Marte.
Lo attendevano migliaia di miglia di navigazione in mare aperto, senza il GPS, o nemmeno un orologio per segnare il tempo, e tutto questo per raggiungere un fazzoletto di terra di sole 20 miglia. Sulla via, pericolose tempeste avrebbero potuto materializzarsi senza preavviso, come poi successe. Forme di vita sconosciute si nascondevano nelle profondità dell’oceano.

Cook prevedeva che la metà dell’equipaggio non sarebbe sopravvissuta. Ma ne Valeva la pena, pensava, per poter osservare un transito di Venere. “Alle 2 di notte issammo le vele e entrammo in mare con a bordo 94 persone,” annotò Cook nel suo diario. Il giovane naturalista della nave Joseph Banks si espresse in modo più romantico, scrivendo: “Prendemmo congedo dall’Europa per solo il cielo sa quanto tempo, forse per sempre,”. La loro missione prevedeva di raggiungere Tahiti prima di giugno 1769, stabilirsi tra gli abitanti dell’isola e costruire un osservatorio astronomico. Cook e il suo equipaggio avrebbero osservato Venere passare davanti alla faccia del sole, e in questo modo avrebbero misurato la dimensione del sistema solare. O comunque questo sperava la Royal Academy inglese, che aveva sponsorizzato l’impresa.
Le dimensioni del sistema solare erano uno dei principali enigmi della scienza del XVIII secolo, un po’ come lo è oggi la natura della materia oscura o dell’energia oscura. Ai tempi di Cook, gli astronomi sapevano che sei pianeti orbitavano il sole (Urano, Nettuno e Plutone non erano ancora stati scoperti) e conoscevano le distanze relative che li separavano – si sapeva, ad esempio, che Giove era 5 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra – ma non era nota la distanza assoluta in miglia.
Venere era la chiave; Edmund Halley se ne era reso conto nel 1716. Visto dalla Terra, Venere ogni tanto attraversa la faccia del Sole. Ha l’aspetto di un disco nero che scivola lentamente attraverso le autentiche macchie solari. Se osservatori situati in punti molto lontani tra loro avessero annotato l’orario di inizio e di fine del transito, pensava Halley, si sarebbe potuta calcolare la distanza tra la Terra e Venere utilizzando il metodo della parallasse. Da ciò sarebbe seguita la scala di tutto il sistema solare.
Tuttavia c’era un problema: la rarità dei transiti di Venere. Essi avvengono a coppie, uno 8 anni dopo l’altro, circa una volta ogni 120 anni. Halley non riuscì a vederne uno nella sua vita. Un team aveva tentato di cronometrare il transito di Venere nel 1761, ma il cattivo tempo atmosferico, insieme ad altri fattori, corruppero i loro dati. Se Cook e altri avessero fallito l’impresa nel 1769, tutti gli astronomi allora esistenti sarebbero morti prima dell’opportunità successiva, che si sarebbe ripresentata solo nel 1874.

La spedizione di Cook viene spesso paragonata a una missione spaziale. “l’Endeavour non aveva intrapreso solo un viaggio di esplorazione,” scrive Tony Horwitz nel suo diario di viaggio di Cook “Blue Latitudes”, “era anche un laboratorio per testare le più recenti teorie e tecnologie dell’epoca, proprio come fanno oggi le navette spaziali.”
Quando Cook raggiunse Tahiti nel 1769, aveva navigato verso ovest per 8 mesi – circa lo stesso tempo che gli astronauti impiegherebbero per raggiungere Marte. L’Endeavour era assolutamente vulnerabile mentre si avvicinava a Tahiti. Nessun contatto con “Mission Control,” nessuna immagine meteorologica via satellite che annunciasse l’arrivo di una tempesta, nessun aiuto di alcun tipo. Cook navigò affidandosi a clessidre, corde con nodi per misurare la velocità della nave, e a un sestante e almanacco per stimare la posizione dell’Endeavour rispetto alle stelle. Un viaggio pieno di insidie e pericoli.
Sorprendentemente, i navigatori giunsero a destinazione, per lo più intatti, il 13 aprile 1769, quasi due mesi prima del transito.

Tahiti era aliena agli uomini di Cook come Marte può sembrarlo a noi oggi. Perlomeno però l’isola era accogliente e ben equipaggiata per ospitare la vita umana e gli isolani erano amichevoli e desiderosi di relazionarsi con gli uomini di Cook. La flora, fauna, e i costumi degli abitanti di Tahiti erano drasticamente diversi dall’Inghilterra, e l’equipaggio dell’Endeavour ne era rapito. Forse per questo Cook e Banks hanno avuto così poco da dire sul transito, quando finalmente si verificò, il 3 giugno 1769. Il piccolo dischetto di Venere, visibile in movimento lungo il Sole acciecante solo con gli speciali telescopi portati dall’Inghilterra, aveva un potente rivale: Tahiti stessa.
Il giorno del transito, Banks scrisse 622 parole nel suo diario; meno di 100 di esse riguardavano Venere. Per lo più, egli raccontò di un incontro a colazione con Tarróa, il Re dell’isola, e sua sorella, Nuna, e più tardi, della visita di “tre graziose signore.” Di Venere dice, “Mi recai dai miei compagni all’osservatorio portando con me Tarróa, Nuna e alcuni dei loro cortigiani; ad essi mostrammo il pianeta davanti al Sole e facemmo loro capire che eravamo venuti appositamente per vederlo. Dopo ciò, essi tornarono indietro, e io con loro.” Fine del racconto. Se il Re o lo stesso Banks fossero rimasti colpiti dallo spettacolo, il diario non ne fa cenno.
Cook fu un po’ più espansivo: “Non avremmo potuto desiderare un giorno più favorevole al nostro scopo, non c’era una nuvola … e l’aria era perfettamente chiara, cosicché abbiamo goduto di tutti i vantaggi per osservare l’intero passaggio del pianeta Venere sul disco del Sole: vedemmo distintamente un’atmosfera, o un’ombra scura, attorno al corpo del pianeta che ha disturbato molto al momento dei contatti, in particolare dei due interni.”
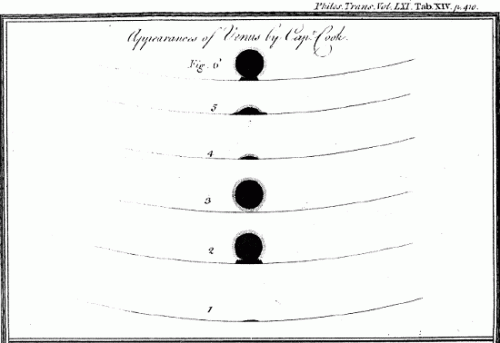
Cook aveva osservato l’effetto “black drop, (goccia nera).” Quando Venere è prossima al lembo del sole – il momento critico per cronometrare il transito – il nero dello spazio oltre il lembo del Sole sembra allungarsi e toccare il pianeta. Ciò rende molto difficile determinare con precisione l’inizio e la fine del transito. L’effetto non fu pienamente compreso fino al 1999, allorché un team di astronomi, sotto la guida di Glenn Schneider dell’Università dell’Arizona, studiarono una black drop analoga durante un transito di Mercurio. Dimostrarono che la distorsione è causata da una combinazione di oscuramento del lembo solare e dalla “spalmatura” dell’immagine di Venere al telescopio. Le osservazioni di Cook furono chiaramente influenzate dal fenomeno. In effetti, le sue misurazioni differivano perfino da quelle dell’astronomo di bordo Charles Green, che aveva osservato il transito accanto a lui, addirittura di 42 secondi.
Anche osservatori in altri luoghi incontrarono queste dificoltà. A conti fatti, le osservazioni del transito di Venere del 1769, effettuate da 76 località in tutto il mondo, inclusa quella di Cook, non risultarono sufficientemente precise per determinare le dimensioni del sistema solare. Gli astronomi non ci riuscirono fino al XIX secolo, quando poterono usare la fotografia per registrare le due coppie di transiti.
Cook non si soffermò su tali questioni; c’era ancora tanto da esplorare. Seguendo ordini segreti dalla Marina, egli lasciò l’isola subito dopo il transito per “cercare tra Tahiti e la Nuova Zelanda un Continente o una Terra molto vasta.” Per buona parte dell’anno successivo, l’Endeavour scandagliò il Pacifico del Sud, in cerca di un continente che secondo alcuni scienziati del XVIII secolo sarebbe stato necessario per bilanciare le vaste distese di terraferma presenti nell’emisfero boreale. Ci fu un periodo in cui non si avvistò terra per quasi due mesi. Ma la terra australis incognita, la sconosciuta “terra del sud”, non esisteva, come dopo tutto Cook aveva sempre pensato. Lungo la via, Cook si imbattè nei poderosi Maori della Nuova Zelanda e negli Aborigeni dell’Australia (incontri per i quali entrambe le etnie avrebbero pagato un prezzo in futuro), esplorò migliaia di chilometri di costiera, ed ebbe una collisione quasi catastrofica contro la Grande Barriera Corallina. L’Endeavour arenata in Australia a seguito della collisione con la Grande Barriera

Più tardi, durante una sosta di 10 settimane a Jakarta per riparazioni, sette marinai morirono di malaria. La città di porto era densamente popolata e piena di malattie. Cook partì il prima possibile, ma il danno era fatto. Complessivamente, il 40% dell’equipaggio perì durante l’impresa, incluso l’astronomo Charles Green, una quota di decessi non considerata particolarmente elevata a quei tempi, scrive Horwitz.
Cook ritornò in Inghilterra l’11 luglio 1771. I sopravvissuti avevano circumnavigato il globo, catalogato migliaia di specie di piante, insetti e animali, incontrato etnie a loro sconosciute, a caccia di giganti continenti. Fu un’avventura epica. In ultima analisi, il transito fu solo un dettaglio nell’impresa di Cook, messo in ombra da Tahiti e rovinata dall’effetto black drop. Tuttavia, Venere e Cook sono profondamente connessi. Qualcuno dice perfino che la ragione più importante per osservare un transito di Venere sia la storia.
Sta a noi decidere. Il 6 giugno 2012 , Venere attraverserà di nuovo la faccia del Sole. L’evento sarà trasmesso sul web, dalle televisioni, e catturato da innumerevoli telescopi di astrofili. In altre parole, non è possibile perderselo! Guardiamo nel disco nero. Potremmo essere trasportati in un altro luogo, in un altro tempo: Tahiti, 1769, quando buona parte della Terra era ancora un mistero e l’occhio al telescopio era quello di un grande esploratore.
Riuscite a sentire la sabbia tra le dita dei piedi?




brava Francesca!
articolo appassionante su una storia avvincente che non conoscevo...
La sento sì la sabbia sotto i piedi.... E vedo anche delle bellissime tahitiane....
Barava, Franci! Molto suggestivo...
Grazie Pier! Sì è davvero una storia curiosa, grazie a science@nasa per avercela raccontata!
grazie Francesca per aver condiviso con noi questa storia, che non avevo mai letto.
mi ha affascinato e fatto sognare.....
grazie
Grazie Red
Bellissimo articolo davvero, una storia che non conoscevo e per me che sono un marinaio é grave.
grande Francy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!